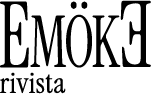Intervista a Jáchym Topol
Nei suoi ultimi romanzi riemerge il tema dell’epoca dell’underground e del samizdat (1968-1989), ovvero l’ambiente della letteratura clandestina, un mondo completamente scomparso che molti non conoscono più. Com’è stato crescere ed emergere come artista in quegli anni?
Proprio in questi giorni sto rispondendo alle domande di un critico musicale che mi ha chiesto di ricordare il periodo in cui cantavo in un gruppo che si chiamava Národní Třída (Corso Nazionale). Mi piace molto ricordare quegli anni – sebbene possa sembrare un po’ strano –. Anche se li ricordo con simpatia, io e i miei amici abbiamo infatti avuto percorsi tormentati e abbastanza simili: siamo stati tutti per periodi più o meno lunghi in prigione, alcuni perfino in manicomio, ed eravamo continuamente perseguitati dalla polizia. La letteratura che ci interessava, eravamo costretti a copiarcela a macchina da soli. Però era un periodo bellissimo, anche se non potevamo fare niente: era una sorta di epoca hippie-punk alla cecoslovacca.
Noi siamo probabilmente l’ultima generazione che ha letto veramente moltissimo. Da giovane mi piacevano i poeti maledetti francesi (Baudelaire, Rimbaud) e ricordo che il mio sogno era quello di una carriera da moderno poeta maledetto. Qualcosa però non è andato nel verso giusto, perché alla fine sono diventato uno scrittore di prosa – se fossi davvero diventato un famoso poeta maledetto, sarei anche dovuto essere morto in questo momento –.
Di quegli anni ricordo soprattutto l’enorme energia. Vivevamo, di fatto, in gruppo, come bande: non avevamo la possibilità di fare lavori normali e, per molti di noi, non è nemmeno stato semplice riuscire a studiare. D’altra parte, queste difficoltà ci hanno portato a una vita comune molto più intensa.
Ma forse il mio ricordo positivo dipende dal fatto che molte cose le ho dimenticate. Io ho un cervello che tende a conservare per il presente soltanto le cose migliori, e quindi molte di quelle negative le ho rimosse.
Allo stesso tempo, la mia è una generazione per cui è stato fortissimo il pericolo di cadere vittime di droga e alcolismo, cose che purtroppo conosco benissimo e che mi hanno fatto sviluppare una certa sensibilità rispetto ai relativi pericoli. Anche mio fratello, in fondo, è finito così.
Il rapporto tra due fratelli, ricorrente nei suoi romanzi, è quindi frutto diretto della sua esperienza? Anche nel suo ultimo libro, Una persona sensibile (Citlivý člověk, 2017; ed. Keller, 2020), è particolarmente evidente la dinamica tra due fratelli, in cui uno è estremamente dipendente dall’altro, al punto da complicare la vita del protagonista.
Hanno influito vari aspetti, e il primo è senz’altro la mia vicenda personale. Mio fratello, Filip Topol, era più giovane di me ed è sempre stato molto fragile, anche se poi è diventato una stella della musica – del rock ceco – ed è morto a causa dell’alcolismo. Io ho sempre mantenuto un fortissimo senso di colpa nei suoi confronti, che mi ha lasciato aperte due strade: o mettermi a fare della psicoterapia oppure scrivere romanzi, e io ho sempre cercato di risolverla in quest’ultimo modo.
Anche se ormai è morto da parecchio tempo, il suo gruppo – i Psí vojáci (Soldati cane) – è ancora molto seguito: anche tra le generazioni più giovani ha un grande successo e i suoi dischi vengono ancora ripubblicati. Mi sono reso conto di essermi occupato forse meno di quanto avrei dovuto della sua tomba al cimitero di Olšany, a Praga, ma di recente ci sono stato e ho visto che ci sono ancora persone che portano i fiori.
Gli altri personaggi dei suoi romanzi sono completamente immaginari oppure si ispirano a persone che ha incontrato nel corso della vita?
Per quanto riguarda la questione del personaggio in senso stretto, potrei dire che i miei personaggi sono, di fatto, un gioco. Sono, cioè, delle scatole costruite in modo complesso: lo stesso personaggio si riflette prima col fratello, poi magari con il suo doppio, e così via. Dal punto di vista strettamente pratico, si tratta di personaggi che nella mia mente maturano a lungo – talvolta anche per anni – prima finire in un romanzo.
Io ho fatto tante cose nella mia vita e direi quasi che questa è stata la mia fortuna: sono passato dal lavorare come operaio a lavorare nelle caldaie, e ho addirittura passato dei periodi in manicomio. Ho trascorso quella che potrebbe essere definita una vita selvaggia, frequentando le famose birrerie praghesi e i loro clienti. Sono esperienze che ho assorbito e – in buona parte – accumulato dentro di me, così quando creo un personaggio ho un grosso serbatoio a cui attingere.
Quando avevo tra i diciassette e i vent’anni, penso di essere stato influenzato proprio da questa tipologia di autori: scrittori che conducevano spontaneamente la propria esistenza, normale o selvaggia che fosse – come nel caso di Jack Kerouac –, ma che vivevano la vita in modo da assorbire situazioni reali che avrebbero poi utilizzato nei propri libri.
I suoi libri si muovono, però, tra un’adesione molto precisa alla storia e una temporalità piuttosto astratta.
Tra le tante stranezze che accompagnano la letteratura, dietro a questo libro c’è – ancora oggi – una sorta di ironia della storia. Quando ho scritto Artisti e animali del circo socialista (Kloktat dehet, 2005; ed. Einaudi, 2011), la storia raccontata è stata percepita in Europa come una grande fantasmagoria: gli scontri tra i carri armati vennero interpretati come avvenimenti che non potevano più succedere. Oggi invece, se ci guardiamo intorno, ad esempio in Ucraina, vediamo tanti uomini che, come il protagonista Ilija, osservano i movimenti dei carri armati. Tutto ciò ha portato, adesso, a un nuovo successo del mio libro, da cui molto probabilmente verrà presto tratto un film.
Questa fortuna, per me come autore, è quindi legata a un grande paradosso. Personalmente ho sempre considerato che la mia fosse una letteratura scritta quasi come requiem di un mondo che stava scomparendo: l’Europa centrale e il periodo del comunismo. Percepivo che si stava avvicinando un mondo in cui ci sarebbe stata la pace, in cui la guerra sarebbe stata presto dimenticata e quindi un mondo in cui nessuno avrebbe più letto questi libri.
Anche in un altro mio libro, L’officina del diavolo (Chladnou zemí, 2009; ed. Zandonai, 2012), viene descritta una guerra civile, quella in Bielorussia. La mia intenzione era semplicemente quella di osservarla attraverso il solito prisma dell’umorismo nero. E, invece, ora è uno dei miei libri più tradotti, proprio perché viene letto come un libro sul presente, sulla Russia, con la quale pensavamo che ci sarebbe stata la pace e invece non ci sarà proprio un bel niente.
A questo punto, ho l’impressione che il mio successo sia in parte basato sulle disgrazie altrui. Io me ne sto qui tranquillo a Praga a riflettere su questi argomenti, pensando che siano cose che appartengono al passato, e invece mi rendo sempre più conto che ogni vero romanzo e ogni vera poesia, alla fin fine, descrivono le disgrazie umane.
Negli ultimi anni è rinata anche una scrittura della memoria legata agli eventi del Novecento e in particolare della Seconda guerra mondiale. Questo tipo di rievocazione, tuttavia, nei suoi libri è spesso unito a una dimensione romanzesca molto forte. La storia, in questi romanzi, rappresenta un modo per arrivare a parlare di un argomento storico oppure è una base per poi finzionalizzare gli eventi e sviluppare il romanzo?
Nei miei romanzi la memoria rappresenta spesso l’architettura di tutto. La memoria, in realtà, è la base della nostra vita, prima sul piano individuale – poiché senza la memoria non saremmo nemmeno in grado di uscire di casa la mattina –, e poi sul piano della memoria collettiva di interi paesi. Ho l’impressione che, senza dei precisi punti condivisi attorno a cui funzionare, il nostro vivere sociale crollerebbe. Questo, nella vita quotidiana, lo osserviamo sia nei bambini, che agiscono senza memoria, sia negli anziani, che talvolta perdono completamente la memoria e non si sanno più orientare nemmeno nel presente.
Per me, la memoria è – a suo modo – un miracolo. Perché ci ricordiamo alcuni episodi insignificanti? Perché ci restano impressi in modo così forte alcuni episodi successi quando avevamo tre anni? Perché, all’interno di un milione di altri episodi forse anche più importanti, risalenti magari ai nostri quindici anni, ci resta un episodio senza nessun significato? In questo, secondo me, risiede la forza della memoria, ovvero la nostra consapevolezza di chi siamo: tutto questo funziona soltanto in presenza della memoria.
La memoria, da questo punto di vista, rappresenta un po’ la mia cassa del tesoro. Questa concezione del valore della memoria si riflette direttamente nei miei romanzi, dove la sua perdita – di piccole porzioni o di più ampie sezioni – porta, in un modo o nell’altro, alla catastrofica rimozione di interi avvenimenti.
Nei miei frequenti viaggi ho sempre messo a confronto, in questo senso, l’atteggiamento della Germania con quello della Russia. Da una parte, mi ha molto colpito quanto fosse importante, per la società tedesca, coltivare la memoria dei traumi. Qualunque bambino tedesco vi saprebbe nominare tutti i campi di concentramento e di sterminio, perché quel tipo di memoria è stato scientemente coltivato. Dall’altra, pur amando la letteratura russa, devo ammettere che già vent’anni fa mi ero reso conto che invece nessuno, sostanzialmente, sa quasi nulla dei gulag e del fatto che Stalin abbia probabilmente ucciso più persone di Hitler. Questo esempio illustra in modo molto evidente quale sia il senso della memoria: nel momento in cui la memoria storica viene del tutto rimossa, possono essere nuovamente replicate le stesse azioni, esattamente nello stesso modo – e forse questo spiega anche la Russia di oggi –.
Una cosa che, infatti, mi colpiva anche nei circoli che frequentavo io è che, dieci o vent’anni fa, parlando di Stalin in Russia, la reazione non fosse mai quella di trovarsi di fronte a una figura diabolica – come nel caso di Hitler –, ma al contrario quella di considerarlo un grande “macho”, una personalità importante della storia russa.
Adesso è emerso uno dei miei grandi difetti: mi sarebbe piaciuto restare sulla letteratura, però tendo – istintivamente – a spostare sempre il discorso verso la politica.
A proposito di politica. Dopo la divisione della Cecoslovacchia, nel 1993, si è passati da un presidente come Havel – anche lui proveniente da un ambiente underground di opposizione –, a un presidente come Václav Klaus, che è arrivato addirittura ad attaccare pubblicamente scrittori come Lei. Come può oggi, la rappresentazione – soprattutto letteraria – della Repubblica Ceca, creare un diverso tipo di dibattito politico?
Ecco un’altra dimostrazione di che cosa sia la poetica, di quale sia la funzione della letteratura. Da un lato, certo, è veramente incredibile pensare che una figura come Klaus, che è stato Presidente della Repubblica di un paese con dieci milioni di abitanti – la Repubblica Ceca –, scriva un articolo* per attaccare, di fatto, quella che è un’opera letteraria, cioè il mio romanzo Una persona sensibile. Dall’altro lato, si potrebbe anche pensare che questa sia la testimonianza di un potere che la letteratura conserva ancora oggi.
Adesso, comunque, la situazione è diversa: il 13 giugno festeggiamo il ventennale della fondazione dove lavoro, la Knihovna Václava Havla (Biblioteca Václav Havel), e incontrerò al Castello di Praga il nuovo Presidente della Repubblica, l’ex generale Petr Pavel. La situazione sarà completamente diversa, ma di nuovo parleremo della mia opera. Questo ha a che fare con il fatto che, dopo Havel, ci sono stati due Presidenti della Repubblica uno peggiore dell’altro, tutti e due politicamente filorussi. Ma la domanda fondamentale è: perché attaccare un romanzo? L’assurdità della situazione si spiega con la volontà di attaccare l’eredità di Havel, e più in generale l’intero dissenso. Dal mio punto di vista, però, devo dire che ha svolto anche una grande funzione pubblicitaria: perfino molti di coloro che avevano smesso di leggere, o che non avevano mai letto, a quel punto – per ripicca – sono andati a comprarsi il mio romanzo.
Questo è però anche indice del mio totale fallimento, perché io, che volevo essere un poeta maledetto, adesso mi ritrovo invece a dialogare con i presidenti. Ed è abbastanza indifferente che la gente apprezzi o meno i miei libri, fatto sta che il mio progetto di poeta maledetto è completamente fallito.
*Ladislav Jakl, Václav Klaus e Jiří Weigl: Smí spisovatel Topol napsat román «Citlivý člověk»? (2017). Articolo a cui Topol ha risposto nell’intervista con Tereza Šimůnková dal titolo O nicotě a ponižování (2017). Entrambi gli interventi, in ceco, si possono leggere qui: https://www.novinky.cz/clanek/kultura-salon-o-nicote-a-ponizovani-rozhovor-s-jachymem-topolem-40037898.
Oggi scrive ancora poesia? Pratica ancora quel genere per cui è diventato famoso come scrittore prima di passare alla prosa?
Sì, però sono testi che scrivo di solito sul cellulare e sono più che altro una valvola di sfogo. Di poesie, in realtà, ne conosco moltissime a memoria. Ancora oggi, ne trovo magari dei frammenti sparsi e mi piace ripetermele in determinati momenti della vita. Un problema è però rappresentato dall’idea oggi diffusa che le poesie migliori siano già state scritte. Questo si sente, per esempio, nella radicale differenza del tasso di violenza che c’è nella produzione odierna: una poesia di oggi non riuscirebbe ad avere l’urgenza e la forza che ha avuto un tempo.
Questa forza sembra averla trasferita invece nei suoi romanzi. Qual è il processo compositivo con cui crea la materia narrativa?
Si tratta di un punto molto rilevante della mia poetica. Si potrebbe anche affermare che il mio modo di scrivere è una lotta contro il caos: potrei riassumerlo con lo slogan «ordine sul caos». Da anni sto scrivendo un nuovo libro – spero di finirlo in estate – e anche stavolta, come al solito, la mia modalità di scrittura non può essere descritta come un processo lineare in cui descrivo una storia, ma consiste invece nella scrittura di centinaia di pagine che poi devo tagliare con l’accetta. Anche in questo caso, do quindi vita a un enorme caos e subito dopo devo combatterlo per riportare il testo a una forma più strutturata.
Per la maggior parte della mia vita, ho avuto, di solito, una normale occupazione: nel periodo socialista ho fatto l’operaio, poi ho lavorato come giornalista e adesso sono impiegato alla Biblioteca Václav Havel. Di conseguenza, la mia idea di letteratura è sempre stata legata al massimo della libertà possibile. Dopo L’officina del diavolo, il mio primo libro ad aver avuto grande eco all’estero, sono finito in quel tourbillon dei meccanismi letterari, e ho cominciato a viaggiare moltissimo, tra le fiere del libro e i festival. Ho iniziato, cioè, a condurre quella che consideriamo la normale vita di uno scrittore, che però ha anche delle controindicazioni: una di queste è che per continuare a frequentare questo mondo bisogna produrre ogni anno un libro. Questo, naturalmente, trasforma anche il mio rapporto con il lettore: è come se io avessi, adesso, un gruppo di lettori che aspettano i miei nuovi romanzi e che, in qualche modo, diventano la mia controparte economica. Questo mi ha dato molto fastidio. Forse è un ideale del passato, ma io sono legato a un’idea più romantica della letteratura.
Sente, con questo ideale, di avere un legame anche con alcuni modelli letterari, in particolare cechi, come Jaroslav Hašek e Bohumil Hrabal?
Questo in realtà è un aspetto che ho sempre sentito abbastanza poco. Anzi, a dire la verità, da giovane odiavo la tradizione letteraria. Hašek e Hrabal sono naturalmente due nomi importanti, fondamentali, a cui vengo accostato spesso. Tuttavia, non mi sembra di avere con loro un legame forte. Ho sempre ricercato voci forti e particolari, mentre le loro mi sembrano voci che difficilmente possono parlare al presente, poiché sono molto legate ad alcuni aspetti del passato. Anzi, se devo essere del tutto sincero, è difficile trovare voci forti nella letteratura recente. Questo ha certamente a che fare con molti cambiamenti, forse anche col fatto che oggi la letteratura non è più così importante com’era un tempo.
Da una parte, il tempo che passiamo a scrivere messaggi o sui social ha trasformato l’idea che abbiamo della scrittura. Dall’altra, anche la lettura è oggi molto diversa: le mie figlie, ad esempio, seguono un percorso autonomo di letture, radicalmente diverso dal mio. I libri rappresentano una parte essenziale della mia vita, ma allo stesso tempo mi rendo conto che il mondo è cambiato. Io sono veramente un uomo dei libri, ciò che mi interessa è starmene in solitudine con un libro. Rispetto al tipo di fruizione che abbiamo oggi, l’enorme differenza della lettura sta nel fatto che bisogna compiere qualcosa anche di estremamente faticoso, ovvero immaginare tutto quello che c’è dietro, che non viene fornito automaticamente.
Un altro aspetto che per il lettore di oggi non è immediato è l’ironia. Nella ricezione dei suoi romanzi all’estero, viene percepita la carica sovversiva dell’umorismo ceco, che è legata soprattutto alla dimensione del grottesco?
A lungo si è pensato che l’umorismo non fosse trasferibile. Io credo, invece, che il successo storico di un personaggio come lo Švejk (Le avventure del buon soldato Švejk, 1921-1923) di Hašek testimoni come l’umorismo possa essere tradotto e condiviso. Ciò che forse cambia in modo radicale è che quel tipo di umorismo era anche sociale, era un umorismo fatto dalle generazioni sconfitte e marginali. Non so se quella tipologia di umorismo possa avere ancora un senso per le nuove generazioni, ovvero se funzioni ancora nel contesto odierno. Per altri aspetti, invece, ho l’impressione che ci si continui a muovere in un universo dove ci sono lo Švejk da un lato e Franz Kafka dall’altro, i quali però – in larga parte – non sono più fenomeni moderni.
Veniamo, per esempio, al discorso di Kafka di cui si parla così tanto quest’anno, in occasione del centenario. Rispetto al ruolo sociale di Kafka, è sicuramente stupefacente quanto sia riuscita la sua trasformazione in icona: a Praga c’è una nuova statua gigantesca dell’artista David Černý e quindi, da un certo punto di vista, Kafka è entrato nella nostra vita quotidiana. Dall’altro lato, però, nutro serissimi dubbi sul fatto che, in questo modo, Kafka venga veramente letto. Ho l’impressione che, con Kafka, sia successa esattamente la stessa cosa che ci succede se entriamo oggi in una chiesa e osserviamo le statue. Spesso non abbiamo la più pallida idea di chi rappresentino e della storia che c’è dietro, o ancora – se si tratta di uno sfondo classico – vediamo rappresentata una divinità ma non sappiamo assolutamente dire che cosa indichi. Questa non vuole assolutamente essere una critica: penso, anzi, che l’operazione di trasformazione di Kafka in icona sia riuscita alla perfezione.
Per tornare però all’umorismo, penso che se dovessi definire in poche parole quali sono la mia poetica e il mio ideale di letteratura – forse chi ha letto Artisti e animali del circo socialista se n’è accorto – direi che c’è sempre il tentativo di far emergere, in qualche modo, l’orrore o il terrore, ma di bilanciare questo elemento con degli aspetti ironici tipici della commedia. È nella tensione tra questi due poli che si articola il mio modo di vedere il mondo.
A proposito di questo libro, come mai il titolo Gargarismi al catrame è stato tramutato dalla casa editrice italiana in Artisti e animali del circo socialista, mentre per la versione inglese è stata scelta la traduzione del titolo originale Gargling with Tar (ed. Portobello Books, 2010)?
Anche se tutte le altre edizioni hanno mantenuto la versione originale, ho acconsentito a cambiare il titolo italiano. All’editore italiano, questi “gargarismi al catrame” sembravano troppo violenti, una cosa troppo underground. Forse dipende dal fatto che, in ceco, questo tipo di umorismo nero è molto importante. Nel contesto ceco, se uno passa davanti a una libreria e vede il romanzo Gargarismi al catrame ha un’iniziale reazione di disgusto, però subito dopo gli viene da ridere. In Italia, forse, è più forte la traccia di tristezza e non scatta la risata.
L’origine di questo titolo, in realtà, è dovuta ai miei studi sulla cultura dei nativi americani dopo la fine delle cosiddette guerre indiane: in quell’occasione avevo letto che i bambini nativi negli orfanotrofi, soprattutto gli apache, venivano obbligati a parlare inglese e invece, tutte le volte in cui utilizzavano la loro lingua nativa, venivano costretti a fare i gargarismi con il sapone. All’inizio pensavo che fosse una crudeltà dei tempi passati, invece poi ho scoperto che anche in Cecoslovacchia, dopo la Seconda guerra mondiale, c’era un orfanotrofio in cui finivano (oltre agli orfani) i figli di famiglie dallo status complicato – ad esempio dei nemici politici che erano stati arrestati o uccisi – oppure di chi era morto in guerra. Spesso, quindi, erano bambini di diverse nazionalità (polacchi, tedeschi, ecc.), e anche in quel caso erano obbligati a parlare in ceco e, se ricorrevano a un’altra lingua, venivano costretti a fare gli stessi gargarismi con il sapone che usavano per lavarsi. Tuttavia, scegliere come titolo del romanzo Gargarismi al sapone mi era sembrato troppo stupido, mentre con il catrame il titolo funzionava meglio.
Per creare romanzi come Artisti e animali del circo socialista ha sfruttato anche la struttura della fiaba?
Sì, è senz’altro uno dei principi su cui ho cercato di costruire tutto il romanzo. In questo caso mi sono aiutato con un trucco d’autore, che è quello di incentrare la vicenda su un protagonista che resta sempre bambino, e che quindi osserva tutto ciò che lo circonda attraverso un pensiero infantile: il suo modo di plasmare il mondo è quello dato dalle fiabe. In particolare, mi sono ispirato al folclore ceco.
Ho cercato di costruire una sorta di mondo fantastico, scrivendo il libro a partire dall’idea di un mio choc personale, di un complesso d’inferiorità. In questo libro – anche se un po’ insensatamente – i cechi lottano con grande coraggio contro chi cerca di invaderli. È questo il complesso che mi porto dietro fin da bambino, cioè il fatto che nel 1968 – quando avevo appena sei anni – noi cechi non ci siamo difesi.
Un aspetto forse meno visibile è la presenza di un’ironia recondita. Si trova soprattutto nella seconda parte del romanzo, quella costruita interamente sulla lotta, sugli scontri di carri armati e sulla tortura dei prigionieri. Mi sono ispirato, in modo a volte anche molto letterale, alla letteratura russa bellica: in queste pagine, infatti, viene quindi ironizzato il filone della letteratura russa realistica.
In questo libro è molto forte anche l’immagine del circo, ma in tanti altri romanzi c’è quest’idea dell’attore, del personaggio itinerante che attraversa tante avventure.
La dimensione del circo rappresenta indubbiamente una caratteristica importante dei miei romanzi, che potrebbero essere inseriti all’interno di quella tradizione letteraria – molto forte in Spagna ma anche in Italia – del romanzo picaresco, al cui centro c’è sempre un protagonista un po’ ambiguo dal punto di vista morale.
Una domanda che, naturalmente, molti si pongono è “Quand’è che noi siamo davvero noi stessi?”. È una domanda latente, che però alle volte emerge in modo molto chiaro: noi siamo diversi a seconda della situazione – quando parliamo con i nostri genitori, quando ci troviamo a scuola, quando incontriamo la nostra vecchia zia, quando ci fermano i poliziotti per strada –, ma quand’è che siamo noi stessi, veramente? Io, molto spesso, riesco ad essere me stesso nei momenti in cui me ne sto da solo a scrivere. Così, quando appaio pubblicamente, mostro una delle tante tipologie diverse di maschere. Anche i miei protagonisti cercano in qualche modo di sopravvivere, attraversano mille avventure diverse e, in fondo, indossano sempre una maschera.
Praga, 7 giugno 2024
Intervista a cura di Giacomo Bottura, Leonardo Guizzetti, Vera Marson e Noemi Quarenghi
Mediazione linguistica di Alessandro Catalano