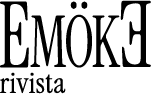Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio
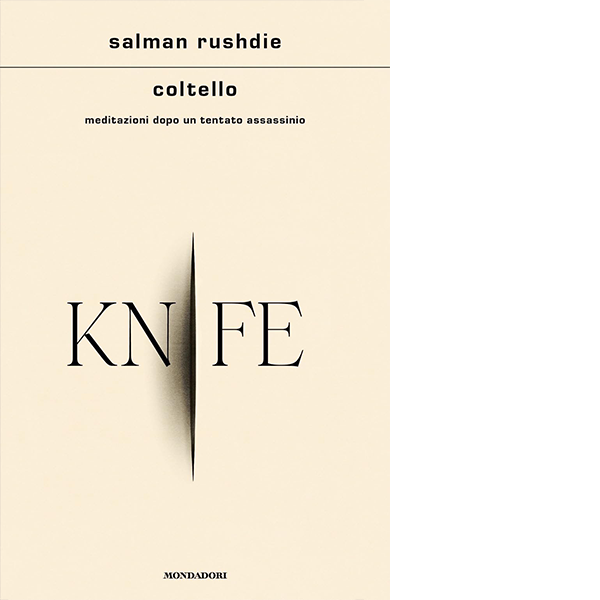
“Anche la lingua è un coltello. Può squarciare il mondo e rivelarne il significato, i meccanismi nascosti, i segreti, le verità. Può aprire un varco da una realtà a un’altra. Può smascherare le fandonie, aprire gli occhi alle persone, creare bellezza. La lingua è il mio coltello. Ero stato colto di sorpresa dal mio aggressore, ma forse avrei potuto usare la lingua come un coltello per difendermi: poteva essere lo strumento giusto per ricostruire e riconquistare il mio mondo, per rimettere insieme la cornice in cui avrei di nuovo appeso alla parete la mia immagine del mondo, per farmi carico di quel che era successo, per assorbirlo, per appropriarmene.” Quello di Salman Rushdie è uno di quei casi in cui la vita e l’opera dello scrittore si incastrano per formare un caso particolarissimo. Tuttavia, per inquadrare questo libro non si tratta tanto di conoscere le sue origini indiane o la sua formazione culturale tipicamente inglese – le due cose vanno di pari passo, per lui, nella Bombay post-indipendenza –; al contrario, si tratta di una produzione che ha preso il sopravvento sul modo in cui l’autore viene percepito, al punto da metterne a repentaglio l’esistenza. Rushdie si è inserito nel discorso postcoloniale con il saggio Non esiste una letteratura del Commonwealth (1983), nel quale ha definito quest’etichetta – sotto la quale dovrebbero rientrare i suoi libri – come una “chimera”, sviluppando ragionamenti estremamente lucidi su lingua e colonialismo, su frontiera e periferia, arrivando a instaurare nessi innovativi tra eclettismo e ghettizzazione della letteratura. Attraverso la propria scrittura – con La città della vittoria (2023) è giunto al suo tredicesimo romanzo – è diventato una delle figure di spicco di questa pretesa “letteratura del terzo mondo”, è riuscito cioè nella complicata ambizione di trovare una voce inedita per parlare di storia e di religione. Da una parte, I figli della mezzanotte (1981), l’opera che l’ha reso celebre, può essere considerato un ultimo grande monumento al realismo magico novecentesco eretto al centro della storia dell’indipendenza indiana. Dall’altra, I versi satanici (1988) ha innescato una serie di controversie culminate nella fatwa, dichiarata dall’ayatollah Khomeini, che l’ha perseguitato per i successivi vent’anni. «Poi, a squarciare quella vita, è arrivato il coltello». I colpi del suo “aspirante assassino” non sono bastati per giustiziare lo scrittore. Anzi, l’attentato, una scossa avvertita dall’intero ambiente letterario, ha dimostrato ancora una volta come la carriera e, soprattutto, la vita di Rushdie non siano riducibili a un singolo evento. Il caso (ormai non più solo) letterario dei Versi satanici l’aveva proiettato al centro di una discussione dalla quale lui era stato estromesso e ridotto a “un’astrazione”. Perciò, la ferita in qualche modo attesa, arrivata a distanza di anni, non si è trasformata nelle stimmate di un martire, ma in una cicatrice che l’autore ha voluto subito ricucire con questo libro. Non è un semplice taglio, ma un nuovo punto in cui si coagula l’esperienza di una figura molto discussa e divisiva, che vuole dare una versione definitiva del proprio rapporto con la religione e con le sue ritorsioni. Come impone il titolo, questa non è un’autobiografia. O meglio, ne è un frammento, che si aggiunge al suo memoir onnicomprensivo, Joseph Anton (2012), e che completa il discorso sull’affaire Rushdie iniziato negli anni Ottanta. In questo nuovo tassello, che non poteva non essere altrettanto tagliente, lo scrittore ha reso l’attacco subìto in occasione di un incontro pubblico il centro gravitazionale dell’opera e vi ha fatto convergere episodi e riflessioni, ricordi precedenti e giudizi successivi, che devono necessariamente passare attraverso il filtro di quella data. Queste meditazioni, tra la quali si insinua di continuo lo spiraglio della possibilità di incontrare il suo attentatore, accelerano all’improvviso con il colloquio immaginario in cui la vittima ricopre anche il ruolo del suo “mancato assassino”: «C’ero io, ma c’erano anche tutte le altre tue realtà, la tua solitudine, i tuoi fallimenti, le tue delusioni, il tuo bisogno di addossare le responsabilità, i tuoi quattro anni di indottrinamento, la tua idea del Nemico. Io ero tutte quelle cose, e tu hai cominciato a pugnalarmi e l’hai trovato terrificante: era bello e terrificante allo stesso tempo». La continua materializzazione dal coltello fra le pagine del libro, con uno squarcio che dal suo interno emerge fino in copertina, mima la serie di pugnalate che costringono l’autore a tornare ossessivamente al vaglio di quell’esperienza traumatica, senza risparmiare sulla corporeità del processo di riabilitazione. Ma, accanto alla materialità con cui si rimargina l’esistenza del Rushdie-uomo, c’è il Rushdie-autore che si fa sentire in ogni capitolo. Proprio in un libro così personale, Salman Rushdie vuole rivendicare la priorità dell’opera sulla vita – o almeno che l’una sopravviva all’altra –, e nel farlo si presenta al lettore come un narratore che descrive e che cita, ma soprattutto che tiene tutto insieme come se fosse la materia di un romanzo. Recensione di Giacomo Bottura Salman Rushdie, Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio, traduzione dall’inglese di Gianni Pannofino, 2024, Mondadori, pp. 240, ISBN: 978-8804780366
Ottimismo crudele
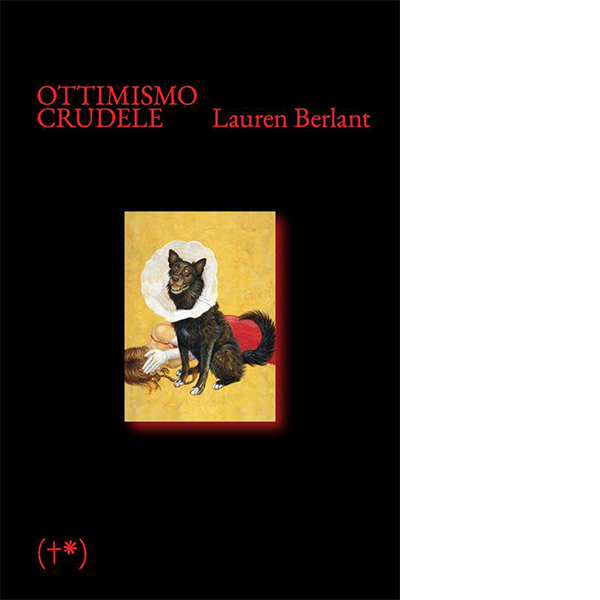
“Una relazione di ottimismo crudele si instaura quando qualcosa che desideri è in realtà un ostacolo alla tua stessa realizzazione. Potrebbe trattarsi di un cibo o di un amore; della fantasia di una buona vita o di un progetto politico […]. Relazioni ottimistiche di questo tipo non sono crudeli di per sé. Diventano crudeli solo quando l’oggetto che suscita il tuo affetto ostacola in maniera attiva l’obiettivo che inizialmente ti ci aveva spinto.” Dopo oltre un decennio dalla sua prima pubblicazione (Cruel Optimism, 2011), Ottimismo crudele di Lauren Berlant è ora disponibile nella traduzione italiana di Chiara Reali e Giorgia Demuro per Timeo, una casa editrice indipendente nata nel 2023. Di grande rilevanza nel panorama della teoria culturale, fin dalla sua uscita, questo saggio ha suscitato un forte interesse negli studi accademici e non solo. Lauren Berlant (1957-2021) è stata una delle figure più influenti nell’ambito della teoria culturale e della critica letteraria. Nella sua opera, infatti, ha sviluppato un approccio originale allo studio delle politiche del desiderio e delle forme di appartenenza sociale, ponendo particolare attenzione ai modi in cui la cultura popolare e i discorsi pubblici modellano le esperienze individuali e collettive. Ottimismo crudele rappresenta l’apice della sua riflessione, che qui trova una forma particolarmente incisiva. A partire dagli anni Ottanta, Berlant osserva come il generale declino dello stato sociale e l’ascesa del neoliberismo nelle democrazie occidentali abbiano minato le promesse di sicurezza e prosperità. Nonostante ciò, le persone continuano ad aggrapparsi a queste promesse, cercando stabilità in modelli di vita che non corrispondono più alla realtà. Questo attaccamento alle fantasie normative del “buon vivere” crea una situazione di crisi dell’ordinarietà, in cui la crisi non è più un evento straordinario, ma diventa parte integrante della vita quotidiana. Berlant sottolinea che il desiderio non è intrinsecamente nocivo, ma diventa “crudele” quando l’oggetto a cui si aspira impedisce, anziché favorire, la realizzazione personale. Questo porta a una condizione di stallo, in cui le persone investono in desideri che limitano la loro crescita. L’autrice attinge a una vasta gamma di materiali – dalla letteratura alla cultura popolare, dal cinema alla filosofia – per costruire una riflessione ampia e stratificata. Il saggio è espressione di una critica culturale in un dialogo costante con l’Affect Theory. Tuttavia, non è un’opera di facile classificazione nemmeno a livello accademico, in quanto mescola approcci e metodologie diverse, rifiutando schematismi rigidi. Lo stile di Berlant è denso e concettualmente sofisticato, e il libro richiede una certa familiarità con il pensiero teorico contemporaneo per essere pienamente apprezzato. Tuttavia, la sua capacità di illuminare le tensioni del presente, offrendo strumenti per comprendere il rapporto tra desiderio, potere e condizione esistenziale, ne giustifica ampiamente le asperità. La pubblicazione in italiano, seppur tardiva, è un contributo fondamentale per il dibattito culturale attuale. Ottimismo crudele non è solo un’opera teorica, ma un’analisi penetrante della condizione contemporanea, che invita a riflettere sulle illusioni che ci tengono legati a modelli di vita insostenibili. Recensione di Vera Marson Lauren Berlant, Ottimismo crudele, traduzione dall’inglese di Chiara Reali e Giorgia Demuro, 2025, Timeo, pp. 480, ISBN: 9791281227071
Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano

“Tolte le pochissime cose di cui possiamo fare esperienza diretta, le nostre opinioni sulla realtà si basano sulla mediazione che ne fanno le altre persone, la cultura popolare, i media, i social media. Non sappiamo quello che accade, se non in minima parte: ci viene raccontato da qualcuno. Sempre.” Quattro anni dopo Questa è l’America (2020), Francesco Costa si è ormai consolidato come uno dei massimi interpreti italiani della cultura americana e dell’attualità statunitense, di fenomeni oggi sempre più complessi che necessitano di un’analisi profonda e consapevole. Nelle pagine di Frontiera si parla di un mondo in cui gli opposti convivono, in cui sembrano dominare le esagerazioni e le contraddizioni, ma il lettore viene subito messo in guardia: «Un’altalena così estrema si deve in parte a un’illusione ottica». Ed è proprio spostando continuamente il punto di vista che Costa illumina i tratti sconosciuti o incompresi degli americani, invisibili all’esterno. Se il risultato di Frontiera è il quadro che promette – e ci consente – di proiettarci in questo «nuovo secolo americano», il mezzo utilizzato ancora una volta da Costa, già sfruttato sia in Questa è l’America che in California (2022), è quello dell’insieme di narrazioni, della serie di frammenti: fatti di cronaca ed episodi di storie piccole o grandi che raramente escono dai loro confini d’origine per arrivare in Europa. Ma la vera originalità di questi racconti sta nella voce che li mette in fila, li interpreta e li riconduce alle categorie più ampie di ‘Abbondanza’, ‘Ingenuità’, ‘Identità’, ‘Violenza’ e ‘Frontiera’. Le cinque parti che compongono il libro non sono altro che cinque diverse angolazioni scelte dall’autore per penetrare l’universo sconfinato degli Stati Uniti, disegnando una panoramica che rimarrà valida ancora a lungo in quanto dipinge l’essenza del popolo americano. Lo sguardo ravvicinato dell’autore, nel mettere a fuoco le diverse caratteristiche degli Stati Uniti, costruisce una percezione degli eventi radicata tanto nella storia quanto nella discussione attuale. Frontiera non è un’apologia degli Stati Uniti o una difesa dei costumi americani, e soprattutto non cerca di ignorare i molti preconcetti sull’America, che vengono invece ribaltati al fine di scoprire ciò che agisce sotto la superficie. L’indagine portata avanti dal neodirettore del Post, puntualmente documentata senza rinunciare alla scorrevolezza della narrazione, osserva la mediazione attuata dai giornali e dalla televisione nei confronti dell’opinione pubblica, e affianca il bias dei media – ideologico ed economico – ai migliori risultati dell’inchiesta giornalistica. Si delinea una riflessione che emerge progressivamente dallo scarto tra i temi affrontati e dalla connessione instaurata ad esempio tra la ricchezza dell’economia, la depressione giovanile e il caso Roe v. Wade, oppure dalla scelta di spostarsi dai dati sulla criminalità e sull’uso di armi, indietro al periodo della segregazione e del Ku Klux Klan, e di nuovo avanti all’amministrazione Trump. Nella vicenda nazionale statunitense la violenza è stata dunque spesso uno strumento di vita quotidiana, di liberazione, di affermazione di sé e di protezione dei propri interessi, dentro e fuori i propri confini. O almeno questo è quello che gli americani amano raccontarsi. Uno strumento: il più pericoloso, delicato, potente, efficace. Una questione tecnica: complicata, dolorosa, inevitabile. Francesco Costa dimostra, dopo anni impegnati nella conduzione della rassegna stampa Morning e nella creazione della newsletter Da Costa a Costa, di aver affinato la capacità di provocare la riflessione del lettore, di non cullarlo nelle sue convinzioni ma di mettergli sotto agli occhi un fatto inedito o, davanti a una storia nota, di sottoporgli una narrazione nuova, uno sguardo provocatorio, una conclusione che precipita verso la stringente necessità di tornare ad agire sul presente. È così, infatti, che prosegue il suo affondo nella questione della violenza legata alle armi: E quindi, dovendo sbrigativamente bilanciare interessi e priorità diverse, può capitare persino che […] un pezzo rilevante della popolazione consideri le decine di migliaia di persone uccise ogni anno dalle armi da fuoco come un prezzo accettabile da pagare pur di proteggere qualsiasi cosa intenda proteggere chi si oppone a una riforma delle leggi sul possesso di armi. Sono danni collaterali, incidenti di percorso. Terribili, ma cosa ci vuoi fare. Recensione di Giacomo Bottura Francesco Costa, Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano, 2024, Mondadori, pp. 290, ISBN: 9788804776888
La felicità è nel giardino

“I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino / di mezzo maggio in un verde giardino.” Questa sembra essere l’origine dell’ispirazione di Guido Davico Bonino nella composizione della sua «guida letteraria», un’antologia in cui sette secoli di letteratura italiana sono ripercorsi seguendo la linea tematica dei giardini. Scegliendo dalla produzione di cinquantasei prosatori e poeti dal Duecento al primo Novecento, l’autore seleziona e commenta passi e pagine in cui la natura, reale o fantastica, è protagonista. «Bellissime scelte […] fanno insieme progetto?». La poliedrica carriera di Bonino, critico teatrale, docente universitario e storico esponente di rilievo della casa editrice Einaudi, garantisce la competenza editoriale su cui si fonda la coerenza progettuale della collezione. Rifuggendo la disorganicità di alcune giustapposizioni antologiche, l’autore lascia infatti intuire, sotto la superficie sensorialmente e stilisticamente appagante dei brani raccolti, le tensioni ideologiche e culturali che sostengono la rappresentazione dei paesaggi. Significativamente il testo è aperto da una citazione dal Libro della Genesi, il cui Giardino dell’Eden esercita notevole influenza su molti degli autori scelti. Dalle suggestioni oltremondane che la natura ispira o finge nei primi capitoli del libro, per mezzo delle composizioni di volta in volta comiche, trattatistiche, intimamente amorose e cavalleresche dei secoli successivi, Bonino ripercorre la varietà letteraria italiana, accostando brani celebri a poeti e prosatori meno noti. Il Purgatorio dantesco figura così accanto al Decameron di Boccaccio e all’Orlando Furioso, ma anche al Viaggio a Costantinopoli di Tommaso Alberti, in un percorso inframmezzato da riproduzioni grafiche tratte da un manuale ottocentesco che giunge fino all’estratto de Il peccato di Giovanni Boine, e accompagna il lettore non soltanto attraverso i giardini, ma nella storia della letteratura stessa. Nonostante il curatore intervenga forse troppo poco sui testi, riservando agli autori un’introduzione minima e lasciando così interamente al lettore la fatica interpretativa, il testo si offre come una piacevole occasione di partecipare del gioioso immaginario naturalistico degli scrittori. Tanto che, in apertura della sezione dedicata ad un brano dello Zibaldone di Giacomo Leopardi, il cui tono può essere riassunto nella frase «Voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento», Bonino sembra avvertire: «Quel Giacomo è davvero un gran rompiscatole!». Recensione di Camilla Maffinelli Guido Davico Bonino, La felicità è nel giardino. Una guida letteraria, 2024, il Saggiatore, pp. 179, ISBN 9788842833215
Opera senza nome
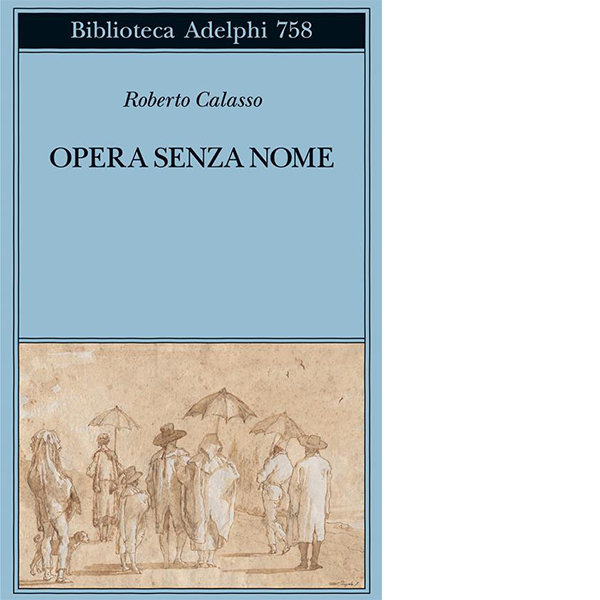
“L’ Opera è qualcosa dove ciò che separa le singole voci è molto più vasto delle voci stesse, simili a isole nella corrente di un mare illimitato. Ogni volta, in quelle isole, lo stile è diverso, come se ospitassero una vegetazione che solo in parte si ripete. Unica è solo la corrente che sostiene l’insieme. Le isole non si avvicinano mai quanto basta per unirsi, al massimo raggiungono una prossimità sufficiente per azzardare fragili ponti. O traghetti. Di regola, occorrono saldi battelli per passare da un’isola all’altra. Talvolta transatlantici.” Opera senza nome è l’espressione con cui Roberto Calasso definisce l’insieme degli undici libri – da La rovina di Kasch (1983) a La Tavoletta dei Destini (2020) – che compongono la sua opera, per la quale rigetta la categoria di ‘enciclopedia’: «Non posso dire che l’unità dell’Opera sia sempre percepita», scrive, «eppure so che questi libri sono concatenati. Forse anche per capirlo meglio ho scritto queste pagine». Per decenni Calasso ha osservato i suoi libri sparpagliarsi nelle biblioteche, non solo in lingue diverse, ma anche tra le sezioni di narrativa e di saggistica, e nel tornare retrospettivamente al momento della creazione dei suoi testi ne rivendica l’originalità ricercata, il desiderio di inventare una forma nuova che «accogliesse occasionalmente frammenti di forme esistenti». Questo libro rappresenta una sorta di testamento interpretativo, una biografia della sua opera, una libera riflessione sulle connessioni profonde che rilegano entro un unico progetto astratto le migliaia di pagine scritte dal fondatore di Adelphi, morto nel 2021. E, per quanto più breve, questo commento autoriale non è meno denso delle opere che ha per oggetto. Mentre il resto del libro segue alcuni nuclei tematici che innervano la sua produzione, il primo capitolo è dedicato alla forma: Calasso si sofferma qui sui generi attribuiti ai suoi testi, sull’uso delle immagini e delle note nelle varie edizioni, sul rapporto tra invenzione e fonti. Nei capitoli successivi diventa evidente come la genesi dei libri presi in esame e la loro successione abbiano lo scopo di mostrare l’intenzione dell’autore in continua evoluzione, di rivelare i fondamenti ragionativi, filosofici e letterari di un’Opera talmente carica di riferimenti da produrre una costellazione di richiami senza un unico centro tematico o ideologico. «Ero attratto dalla possibilità di accumulare racconti e materiali di ogni sorta e di celare il pensiero fra le righe della narrazione», scrive l’autore di Le nozze di Cadmo e Armonia (1988), «inclinazione per le storie che inglobano il pensiero, piuttosto che per l’inverso». L’Opera senza nome, a sua volta, pur spaziando tra diversi campi del sapere – emblematici in questo senso Il rosa Tiepolo (2006) e La Folie Baudelaire (2008) –, non tratta i libri su cui si fonda come singole voci enciclopediche, ma li mescola ripetutamente: i personaggi che li abitano permettono un dialogo indiretto, in cui sono i libri stessi a comunicare tra loro, accostati dalla voce dell’autore che conosce i punti di contatto tra episodi lontani. Questo volume è un post scriptum che rivela un legame più profondo fra le opere di Calasso, ma funziona, al tempo stesso, come un’introduzione che poteva essere scritta solo a conti fatti. Quello che resta da capire è come, nel concreto, l’autore sia in grado di compiere un’operazione così ambiziosa; l’unico modo possibile è riportarne un esempio: Una estrema vicinanza o quasi sovrapposizione nel titolo si ha fra Ka (1996) e K. (2002). E al tempo stesso la massima distanza (Kafka ha avuto ben pochi contatti con l’India e i testi indiani). Di fatto, K. prova a mostrare esattamente perché e come il personaggio chiamato K. in Kafka è diverso da qualsiasi altro personaggio nella storia del romanzo, così come Prajāpati era diverso da ogni altro dio del pantheon vedico. Dopo tutto, i libri nascono anche così, da qualche riga in un libro precedente dell’autore, che può essere radicalmente differente, come lo è Ka da K. Già per questo: Ka tratta di una prodigiosa molteplicità di dèi e demoni mentre Kafka puntigliosamente evita il nome Dio e, se anche talvolta parla di “dèi”, questo accade assai di rado e con ogni cautela. Recensione di Giacomo Bottura Roberto Calasso, Opera senza nome, 2024, Adelphi, pp. 160, ISBN: 9788845938931