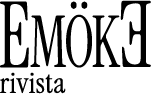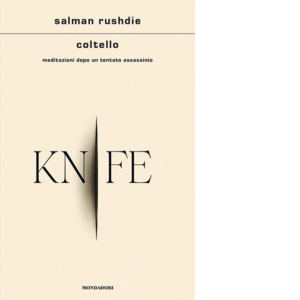
“Anche la lingua è un coltello. Può squarciare il mondo e rivelarne il significato, i meccanismi nascosti, i segreti, le verità. Può aprire un varco da una realtà a un’altra. Può smascherare le fandonie, aprire gli occhi alle persone, creare bellezza. La lingua è il mio coltello. Ero stato colto di sorpresa dal mio aggressore, ma forse avrei potuto usare la lingua come un coltello per difendermi: poteva essere lo strumento giusto per ricostruire e riconquistare il mio mondo, per rimettere insieme la cornice in cui avrei di nuovo appeso alla parete la mia immagine del mondo, per farmi carico di quel che era successo, per assorbirlo, per appropriarmene.”
Quello di Salman Rushdie è uno di quei casi in cui la vita e l’opera dello scrittore si incastrano per formare un caso particolarissimo. Tuttavia, per inquadrare questo libro non si tratta tanto di conoscere le sue origini indiane o la sua formazione culturale tipicamente inglese – le due cose vanno di pari passo, per lui, nella Bombay post-indipendenza –; al contrario, si tratta di una produzione che ha preso il sopravvento sul modo in cui l’autore viene percepito, al punto da metterne a repentaglio l’esistenza.
Rushdie si è inserito nel discorso postcoloniale con il saggio Non esiste una letteratura del Commonwealth (1983), nel quale ha definito quest’etichetta – sotto la quale dovrebbero rientrare i suoi libri – come una “chimera”, sviluppando ragionamenti estremamente lucidi su lingua e colonialismo, su frontiera e periferia, arrivando a instaurare nessi innovativi tra eclettismo e ghettizzazione della letteratura. Attraverso la propria scrittura – con La città della vittoria (2023) è giunto al suo tredicesimo romanzo – è diventato una delle figure di spicco di questa pretesa “letteratura del terzo mondo”, è riuscito cioè nella complicata ambizione di trovare una voce inedita per parlare di storia e di religione. Da una parte, I figli della mezzanotte (1981), l’opera che l’ha reso celebre, può essere considerato un ultimo grande monumento al realismo magico novecentesco eretto al centro della storia dell’indipendenza indiana. Dall’altra, I versi satanici (1988) ha innescato una serie di controversie culminate nella fatwa, dichiarata dall’ayatollah Khomeini, che l’ha perseguitato per i successivi vent’anni.
«Poi, a squarciare quella vita, è arrivato il coltello».
I colpi del suo “aspirante assassino” non sono bastati per giustiziare lo scrittore. Anzi, l’attentato, una scossa avvertita dall’intero ambiente letterario, ha dimostrato ancora una volta come la carriera e, soprattutto, la vita di Rushdie non siano riducibili a un singolo evento. Il caso (ormai non più solo) letterario dei Versi satanici l’aveva proiettato al centro di una discussione dalla quale lui era stato estromesso e ridotto a “un’astrazione”. Perciò, la ferita in qualche modo attesa, arrivata a distanza di anni, non si è trasformata nelle stimmate di un martire, ma in una cicatrice che l’autore ha voluto subito ricucire con questo libro. Non è un semplice taglio, ma un nuovo punto in cui si coagula l’esperienza di una figura molto discussa e divisiva, che vuole dare una versione definitiva del proprio rapporto con la religione e con le sue ritorsioni.
Come impone il titolo, questa non è un’autobiografia. O meglio, ne è un frammento, che si aggiunge al suo memoir onnicomprensivo, Joseph Anton (2012), e che completa il discorso sull’affaire Rushdie iniziato negli anni Ottanta. In questo nuovo tassello, che non poteva non essere altrettanto tagliente, lo scrittore ha reso l’attacco subìto in occasione di un incontro pubblico il centro gravitazionale dell’opera e vi ha fatto convergere episodi e riflessioni, ricordi precedenti e giudizi successivi, che devono necessariamente passare attraverso il filtro di quella data. Queste meditazioni, tra la quali si insinua di continuo lo spiraglio della possibilità di incontrare il suo attentatore, accelerano all’improvviso con il colloquio immaginario in cui la vittima ricopre anche il ruolo del suo “mancato assassino”:
«C’ero io, ma c’erano anche tutte le altre tue realtà, la tua solitudine, i tuoi fallimenti, le tue delusioni, il tuo bisogno di addossare le responsabilità, i tuoi quattro anni di indottrinamento, la tua idea del Nemico. Io ero tutte quelle cose, e tu hai cominciato a pugnalarmi e l’hai trovato terrificante: era bello e terrificante allo stesso tempo».
La continua materializzazione dal coltello fra le pagine del libro, con uno squarcio che dal suo interno emerge fino in copertina, mima la serie di pugnalate che costringono l’autore a tornare ossessivamente al vaglio di quell’esperienza traumatica, senza risparmiare sulla corporeità del processo di riabilitazione. Ma, accanto alla materialità con cui si rimargina l’esistenza del Rushdie-uomo, c’è il Rushdie-autore che si fa sentire in ogni capitolo. Proprio in un libro così personale, Salman Rushdie vuole rivendicare la priorità dell’opera sulla vita – o almeno che l’una sopravviva all’altra –, e nel farlo si presenta al lettore come un narratore che descrive e che cita, ma soprattutto che tiene tutto insieme come se fosse la materia di un romanzo.
Recensione di Giacomo Bottura
Salman Rushdie, Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio, traduzione dall’inglese di Gianni Pannofino, 2024, Mondadori, pp. 240, ISBN: 978-8804780366