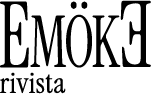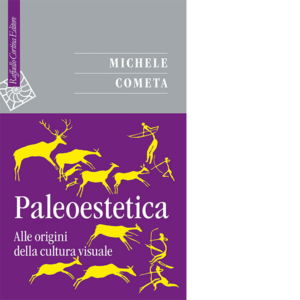
“Si tratta […] di prendere atto del fatto che ancora oggi siamo in grado di “vedere” qualcosa (anzi più che qualcosa) quando contempliamo le immagini del Paleolitico e dunque che possiamo dare per scontata una continuità cognitiva tra noi e i nostri predecessori, ma soprattutto una continuità nei nostri comportamenti al cospetto delle immagini, come pare emergere da tutta la letteratura scientifica”.
Forte delle persistenze – tanto cognitive quanto comportamentali – che ci legano ai nostri antenati quando ci troviamo innanzi alle immagini, Michele Cometa in Paleoestetica. Alle origini della cultura visuale tenta di ricostruire le culture visuali paleolitiche a partire dall’analisi comparata di più artefatti.
Per fare questo, da un punto di vista metodologico, gli strumenti della cultura visuale sono messi in dialogo con gli assunti della prospettiva bioculturale, due filoni di ricerca ampiamente approfonditi dal critico; laddove la seconda sensibilità è centrale, ad esempio, in Letteratura e darwinismo. Introduzione alla biopoetica (Carocci, 2018), la prima figura tra i suoi interessi principali. Cometa è infatti uno tra i massimi mediatori e interpreti italiani del pensiero di W. J. T. Mitchell, tanto da aver curato con Valeria Cammarata la raccolta Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale (Raffello Cortina Editore, 2017) – nella quale sono riunite le teorizzazioni più rivoluzionarie del critico statunitense – e ha formulato sue proprie riflessioni sulla disciplina, come in Cultura visuale (Raffello Cortina Editore, 2020), in cui, attraverso Warburg, Freud e Benjamin, viene tracciata la genealogia della materia.
In Paleoestetica, nello specifico, la cultura visuale diviene uno strumento che, al fianco dell’antropologia culturale e delle neuroscienze cognitive, permette di interpretare in maniera innovativa incisioni e manufatti risalenti al Paleolitico, con la consapevolezza che essi sono sia incarnazioni sia modificatori del pensiero dell’uomo a quell’altezza cronologica e nel dato contesto in cui sono stati realizzati. Accantonando tanto le proiezioni attualizzanti (o paleofantasie) quanto le semplificazioni livellanti (per cui non esisterebbero distinzioni di natura temporale e/o spaziale tra i vari oggetti di studio), Cometa intende così «tracciare una (nuova) estetica ambientale», una paleoestetica appunto.
A questo scopo, al saggio viene data una precisa struttura: il primo e il secondo capitolo sono funzionali a delineare la materia e il metodo, laddove i restanti tre presentano degli affondi sui concetti di superficie, corpo e ibrido, tre tensioni che animano il fare-immagine già in quel periodo della storia di Homo Sapiens. Offrendo delle suggestioni che appianano la distanza che ci separa dai nostri predecessori paleolitici, il critico nella seconda parte di Paleoestetica presenta così una panoramica che spazia dalle pareti-schermo (e dalla sensibilità proto-cinematografica che vi sta alla base) fino alla creazione di miniature e al principio dinamico di metamorfosi.
Il risultato è un saggio illuminante, complici la chiarezza espositiva e la riproduzione dell’apparato iconografico di riferimento: in questo modo, il lettore è guidato dal critico ad esercitare una lettura analitica di quanto va guardando, senza che questi si abbandoni solamente allo stupore che incisioni e pitture rupestri inevitabilmente inducono.
Recensione di Serena Scolari
Michele Cometa, Paleoestetica. Alle origini della cultura visuale, 2024, Raffaello Cortina Editore, pp. 328, ISBN: 9788832856774