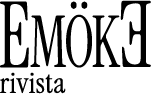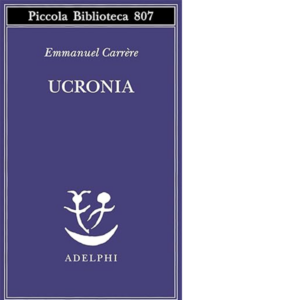
“Proprio di questo si tratta: della storia se le cose fossero andate diversamente”
«Che cos’è davvero determinante nella storia dell’umanità? In che modo l’uomo si rappresenta la concatenazione di cause ed effetti a cui la storia si riduce? E, a tal proposito, la storia si riduce davvero a questo? Ha un senso? E chi si occupa di farlo rispettare? E, se ce l’ha, è possibile cambiarne il corso? Di cosa sono fatti i nostri rimpianti, come si sfilano le maglie nel tessuto delle nostre vite?». Sono queste solo alcune delle domande al centro del saggio Ucronia (Le Détroit de Behring, Introduction à l’uchronie) di Emmanuel Carrère, pubblicato in Francia nel 1986 e nel 2024 in Italia.
Autore di saggi, romanzi e traduzioni, Carrère è tra gli scrittori più rilevanti del panorama letterario internazionale. In Ucronia, uno dei nodi principali della riflessione è rappresentato dall’indagine sul rapporto tra l’uomo e la religione cattolica, discorso che sarebbe poi stato portato avanti ne Il Regno (Le Royaume, 2014; ed. Adelphi, 2015) e in V13 (V13, 2022; ed. Adelphi, 2023), cronaca giudiziaria che raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti agli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015.
Quando Carrère compone il saggio, lo studio dell’Ucronia è ancora tutto da scrivere, e la parola stessa è poco nota. Coniato nel 1876 dal filosofo francese Charles Renouvier nell’omonima opera Ucronia, il termine deriva dal greco ou-chrónos: che non è in nessun tempo. Il sottotitolo del testo di Renouvier recita: Schizzo storico apocrifo dello sviluppo della civiltà europea, non come è stato, ma come avrebbe potuto essere. «Proprio di questo si tratta: della storia se le cose fossero andate diversamente» precisa Carrère; «l’intento, scandaloso, dell’ucronia è […] quello di cambiare ciò che è stato». L’ucronia non ha mai potuto assurgere alla dignità di genere letterario, a differenza dell’utopia (dal greco ou-tópos: che non è in nessun luogo); «le fantasticherie retrospettive restano per lo più inespresse, o espresse solo a voce», commenta l’autore. Il fatto che negli anni ’80 non esistesse una bibliografia sul tema non significava, tuttavia, che nessuno avesse mai scritto ucronie: in questo saggio, Carrère si propone di esaminare alcuni esperimenti di «menti curiose» che hanno provato a domandarsi: «Che cosa sarebbe successo se…?».
Carrère guida chi legge alla scoperta di come l’ucronia possa essere strumento di potere e forma di discorso politico, ma anche fonte di spassosi equivoci: «da quando il romanziere americano Howard Phillips Lovecraft e i suoi sodali hanno basato i loro racconti fantastici su una mitologia e un corpus di testi sacri immaginari», racconta l’autore, «tutti i bibliotecari del mondo si vedono periodicamente chiedere i Manoscritti pnakotici o il terrificante Necronomicon dell’arabo pazzo Abdul Alhazred».
Il cuore del discorso si sviluppa a partire da una domanda: se il Cristianesimo non fosse esistito, che cosa sarebbe successo? Il tema, indagato anche nel Regno, viene trattato seguendo gli snodi di Ponzio Pilato (Ponce Pilate, 1961; ed. Einaudi, 1963) di Roger Caillois, opera in cui si entra in ucronia immaginando che Ponzio Pilato, dopo una notte insonne, decida di non condannare Gesù Cristo, ma Barabba. Carrère prosegue interrogandosi sul valore del libero arbitrio e sull’impatto immenso della religione cristiana nel mondo in cui viviamo.
Ucronia mira a porre l’attenzione su un «argomento importante» con il tono ragionativo di uno stile conversazionale, distintivo dei testi di Carrère. Il saggio risulta accessibile anche senza una profonda consapevolezza filosofica, in quanto la voce autoriale espone le proprie considerazioni, accompagnando chi legge in un dialogo, perché «tutti, giorno dopo giorno, nutrono di simili imposture il romanzo della loro vita» e, dunque, possono comprendere.
Recensione di Noemi Quarenghi
Emmanuel Carrère, Ucronia, traduzione dal francese di Federica Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco, 2024, Adelphi, pp. 160, ISBN: 9788845939167